Effetti giuridici delle violazioni di fatto dello Statuto da parte dello Stato Italiano: ex injuria non oritur jus (le illegittimità sono insanabili) (I parte)
Premessa: le Repubbliche Baltiche
Tutti sanno (più o meno) quali sono e dove si trovano le repubbliche baltiche: Estonia, Lettonia, Lituania.
Quasi tutti sanno che queste repubbliche si sono staccate dall’Impero Russo alla fine della Prima guerra mondiale e sono rimaste indipendenti nel periodo tra le due guerre. Poi, per effetto del patto Molotov-Ribbentrop, furono occupate dall’Unione Sovietica nel 1940, rioccupate dalla Germania nazista l’anno dopo, ri-rioccupate da Stalin durante la “Ritirata di Russia” e quindi “definitivamente” incluse nell’Unione Sovietica; definitivamente fino al 1991, quando, dissolta la stessa, hanno ripreso il loro posto nella storia e nella carta geografica europea.
Insomma: indipendenti tra le due guerre mondiali, e poi di nuovo dal 1991.
Quello che pochi sanno è invece che nel 1991 non c’è stata alcuna dichiarazione di separazione dall’URSS. I governi delle Repubbliche baltiche si sono considerati IN CONTINUITÀ GIURIDICA con i vecchi governi di anteguerra, considerando la parentesi sovietica nient’altro che una occupazione illegittima. Gran parte della comunità internazionale (non la Federazione Russa, ovviamente), ha riconosciuto questo passaggio. Durante la Guerra Fredda i paesi occidentali avevano un atteggiamento ambiguo, tra il riconoscimento di fatto dell’occupazione sovietica, e il mantenimento di relazioni, sempre più scialbe invero, con governi-ombra all’estero.
La teoria della continuità giuridica e la Sicilia del 1848
Perché mi interessa la questione? Perché mi chiedo se una cosa del genere non possa dirsi anche dei rapporti tra Sicilia e Italia.
Non sarebbe la prima volta che ciò avviene. La “Teoria della continuità giuridica” è stata già applicata in Sicilia, e – infine – è stata pure accolta dalla comunità internazionale.
Quando, infatti, nel 1848, con le armi i Siciliani cacciarono i Borbone da tutta la Sicilia (ad eccezione della sola “Cittadella” di Messina) non dichiararono alcuna “indipendenza” dal Regno delle Due Sicilie. Il Governo di Ruggiero Settimo semplicemente considerò quella borbonica un’usurpazione, un’occupazione illegittima che durava dal 1816. Non a caso il Parlamento Siciliano dichiarò in quell’occasione la decadenza perpetua del Borbone dal trono “di Sicilia”. Il trono “delle Due Sicilie” neanche esisteva per noi Siciliani. Il Governo provvisorio convocò un Parlamento secondo la Costituzione del 1812, l’unica considerata legittima. La Costituzione del 1848 non fu una costituzione “rivoluzionaria”, ma fu votata da un Parlamento eletto secondo la precedente costituzione (quella del 1812 appunto). Il Regno di Sicilia del 1848/49 (un regno senza re, con le funzioni di Capo di Stato esercitate da un “Presidente” in via provvisoria) non è “un altro stato” rispetto a quello ante 1816. È lo stesso: il medesimo Regno di Sicilia, considerato unico legittimo rappresentante della Nazione Siciliana.
Le ragioni erano più che valide. La “fusione delle corone” del 1816 era di una mostruosità giuridica senza precedenti: vietata espressamente dalla Costituzione, non conforme al dettato del Congresso di Vienna che “restaurava sul trono di Napoli” Ferdinando e lo proclamava sì, “re del regno delle Due Sicilie”, ma questa forma pleonastica, voluta fortemente e subdolamente dal Medici, era vista né più né meno che come una restaurazione della formula tradizionale “rex utriusque Siciliae”, cioè re di entrambi gli “omonimi” regni di Sicilia (al di qua e al di là del “Faro”), come erano conosciuti e riconosciuti internazionalmente dal 1443, anno in cui Alfonso il Magnanimo era diventato Re di Napoli (teoricamente Regno di Sicilia al di qua del Faro), oltre che Re di Sicilia (teoricamente al di là del Faro).
Il Decreto dell’8 dicembre 1816 era un tradimento, un colpo di stato, una annessione illegittima di un paese vincitore delle Guerre Napoleoniche (il Regno di Sicilia) a un regno sconfitto (il Regno di Napoli).
La continuità tra il Regno storico (1130-1816) e quello “rivoluzionario” (1848-49) era giuridicamente ben fondata e indiscutibile. Soltanto non ebbe il tempo di ottenere quei riconoscimenti internazionali che ne avrebbero sancito l’irreversibilità, ma soltanto relazioni di fatto, con Francia e Regno Unito.
Ma anche prima…
Il Regno di Sicilia, dopo il Vespro, aveva ottenuto il diritto internazionale alla sua indipendenza con il Trattato del 1372 (unica limitazione l’accettare il titolo diminutivo “di Trinacria”, ciò che cadde poi nel 1443, come abbiamo visto), e mai questo diritto fu messo in discussione, anche quando il re di Sicilia era “anche” re di Spagna o di qualsiasi altro paese straniero. Il riconoscimento internazionale è cosa lunga, ci vogliono anni e guerre. La Sicilia del Vespro ci aveva messo 90 anni per farsi riconoscere.
Ancora prima, Ruggero II ci mise 9 anni per farsi riconoscere dal Papa dopo la fondazione del Regno. Per farsi riconoscere dall’Impero d’Oriente bisogna attendere il figlio Guglielmo I il Malo. Per farsi riconoscere anche dal Sacro Romano Impero, addirittura la Pace di Venezia e il nipote Guglielmo II il Buono. Il Governo di Ruggero Settimo non ebbe tutto questo tempo a disposizione, perché le armate borboniche rientrarono in Sicilia, reiterando l’usurpazione e l’occupazione illegittima, già nel maggio del 1849.
Ma il principio della continuità giuridica resta salvo, suggellato dal sangue dei Siciliani, che dal 1816 al 1860 (incluso) non accettarono mai l’occupazione.
E del resto, per quanto faccia venire il capogiro, persino Ruggero II, nel proclamarsi Re, usò – per come poteva farsi ai tempi – il principio della continuità, questa volta con il “Regno Siceliota” di Agatocle, Pirro, Ierone II… Il Regno di Sicilia nel 1130 non venne “creato”, ma semplicemente “restaurato”, dopo secoli di incorporazione come provincia nell’Impero (illegittima?) e di occupazione islamica. Artificio ideologico? Diciamo piuttosto finezza giuridica, che – come abbiamo visto – nel mondo contemporaneo sarebbe stata usata a piene mani. Perché la “restaurazione baltica” sarebbe meno artificiosa di quella ruggeriana o del 1848?
Il Regno di Sicilia sarebbe, così, uno degli Stati più antichi del mondo. Nato per progressiva fusione tra le antiche città-stato sicule e siceliote (l’egemonia siracusana, poi diventata “symmachia”, cioè confederazione, e infine vero e proprio “Regno”) sarebbe sopravvissuto per millenni, da un punto di vista giuridico, e arrivato… fino al 1860. Poco importa il fatto. Quello che conta è il diritto: da un’offesa, come lo è un’occupazione illegittima, non nasce alcuna legittimità. Il brocardo latino citato in titolo significa proprio questo: ex injuria non oritur jus. Solo i Siciliani, legittimamente, possono decidere di dissolvere il loro stato in qualcosa di più ampio.
E quindi? Quand’è che siamo diventati “Italiani”?
Ora, mi chiedo, quando è accaduta questa “dissoluzione” nell’Italia?
Andiamo avanti. Ruggiero Settimo nel 1849 si rifugia a Malta, accolto con gli onori di un Capo di Stato all’estero (e lo era) ma, per mancanza di risorse e di salute, non costituisce un vero e proprio Governo siciliano all’estero.
Quando Garibaldi, sotto protezione britannica, sbarca a Marsala, Ruggiero Settimo non ha la forza di disconoscere pubblicamente la Dittatura Garibaldina, essendo lui stesso ospite di quegli stessi inglesi che hanno orchestrato l’operazione. Com’è come non è, la sua senile acquiescenza (di lì a poco sarebbe morto, non andando mai a sedere come Presidente del Senato a Torino) dà qualche valore al regime transitorio dell’avventuriero nizzardo, nel vuoto di potere che si crea alla fuga degli occupanti borbonici e al dissolvimento delle loro strutture.
Garibaldi a Salemi e negli altri atti definisce in Sicilia i Borboni “usurpatori”, cioè occupanti illegittimi. E sin qui ci siamo. Siamo in linea con la “continuità”. Furbescamente assume la Dittatura di “Sicilia” e non di “Due Sicilie”, accarezzando la concezione separatista dei Siciliani.
Ad Alcamo costituisce un Governo statale di Sicilia, non un governo sulla parte libera delle “Due Sicilie”. La statualità separata della Sicilia è fuori discussione.
Di più: le norme emanate dal Governo 1848/49 sono richiamate in vigore e quelle dell’occupazione borbonica successiva abrogate.
Il quadro giuridico è chiarissimo. Garibaldi, con questi atti, sposa la teoria della continuità dello Stato di Sicilia (che evita furbescamente di chiamare “Regno di Sicilia”) e – QUESTO IL DATO IMPORTANTISSIMO – in questa operazione ottiene immediatamente il generalizzato riconoscimento internazionale. La comunità internazionale, letteralmente dalla sera alla mattina, dà per acquisito il fatto che la Sicilia ha un suo governo, ancorché transitorio, e che quella napoletana è stata solo un’occupazione illegittima.
Il Governo dittatoriale (da maggio a dicembre del 1860) è un Governo provvisorio dello Stato di Sicilia che si proclama in piena continuità giuridica con il Regno di Sicilia ed è riconosciuto in modo sostanzialmente globale. Commette varie e gravissime illegittimità costituzionali sul piano interno, tutte nulle a mio avviso, ma questo non toglie nulla alla legittimità internazionale dello Stato di Sicilia. La nullità degli atti è tutta interna.
Nullo il recepimento in Sicilia dello Statuto Albertino, ad esempio. Perché le modifiche costituzionali erano tassativamente regolate dallo Statuto in quel momento vigente del 1848.
Legittima la Convocazione di un’Assemblea parlamentare per il 21 ottobre, se mai questa fosse stata convocata con le regole del 1848.
Nulla invece la sua “trasformazione” in plebiscito-farsa per “ordine” di un Governo straniero come era in quel momento il governo di Cavour.
In poche parole, per farla breve, la “fusione” dello Stato di Sicilia con l’Italia sarebbe basata su principio di diritto naturale: l’autodeterminazione dei popoli. Sarebbe stato il Popolo Siciliano che, con plebiscito del 21 ottobre 1860, avrebbe deciso di diventare in tutto e per tutto “Italia” e di ammainare la bandiera dello Stato di Sicilia che sventolava addirittura dall’Antichità.
1860-1943: un’occupazione illegittima. E poi?
Ma – come è noto – quel plebiscito è nullo in tutti i suoi aspetti. Nullo per presupposti giuridici nella Costituzione del 1848. Nullo per modalità di convocazione, per modalità non segrete di votazione, per ambiguità del quesito formulato, per condizionamenti militari sul voto, etc.
L’annessione dello Stato di Sicilia all’Italia poggia su un atto nullo. Gli atti seguenti, a valle, sono travolti da questa nullità. Il Plebiscito del 1860 non è più regolare del decreto del 1816. Si tratta di emerite “buffonate”: perché mai dovrebbe essere falso il secondo e accettabile il primo? Perché “nel fatto” poi nessuno ha avuto la forza di ribaltarne il risultato? Troppo poco. Ex injuria non oritur jus. E la “injuria” del 1860 non è “più bella” di quella del “1816”.
Lo Stato di Sicilia, quindi, è occupato dal 1860 dall’Italia, che illegittimamente, anche per mezzo di uso più volte di legge marziale, lo trattiene al proprio interno.
Fin quando dura questa illegittimità? I fatti della II Guerra mondiale e successivi interrompono o no lo stato illegale di occupazione della Sicilia? Lo Statuto del 1946 pone fine a tutto ciò?
Intanto è certo che fino alla II Guerra mondiale nulla cambia. Nulla cambia perché sino al 1913 la Sicilia è – come tutta l’Italia – a suffragio ristretto. Mai la maggioranza dei Siciliani è stata chiamata a votare ed ha ufficialmente accettato lo Statu quo. Anzi, le continue repressioni militari, fino al 1895, e la successiva esplosione del Regionismo politico (l’unica forma di dissenso che si poteva esprimere liberamente) testimoniano il contrario. Anche nelle poche elezioni libere e a suffragio universale maschile (1913, 1919, 1921) la maggioranza dei cittadini siciliani non va a votare. Durante la I Guerra Mondiale i diritti politici sono sospesi. Nel periodo successivo è il caos sociale e politico, culminato con l’instaurazione della Dittatura Fascista. Le elezioni del 1924 (Legge Acerbo) sono già l’anticamera del totalitarismo. Poi più nulla fino alla II Guerra mondiale, dato che i plebisciti fascisti sono condotti con le stesse regole-farsa di quello del 1860 (1929 e 1934). Curioso che l’Italia oggi riconosca la legittimità del plebiscito garibaldino e condanni quelli fascisti, svoltisi ESATTAMENTE con le stesse regole (schede prevotate, urne separate e voto palese, senza alcuna previsione degli esiti se avesse vinto il NO). Nel 1940 la deportazione dei funzionari siciliani. Già dal 1942 la comparsa del Separatismo che esplode dopo lo sbarco alleato.
No, nessun dubbio. Fino al 1943 la Sicilia è semplicemente “occupata” dall’Italia. Lo Stato di Sicilia, anzi, teoricamente, il “Regno di Sicilia” è vivo e vegeto.
Ma dopo?
Di questo ci occuperemo una prossima volta.

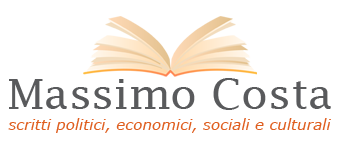



Molto chiari tutti i passaggi. Mi sfugge solo una cosa: perché nel 1913, 1919 e 1921 i cittadini siciliani non andarono a votare? Si votava per Camera e Senato del Regno d’Italia? Quali le ragioni della diserzione delle urne? L’analfabetismo? Il non sentirsi rappresentati, ecc.
Probabilmente l’impreparazione di molti Siciliani a una vita democratica. Nel 1913 si votava ancora con i collegi uninominali in cui si presentavano i notabili. Vero che ci fu un’esplosione di voti per i socialisti (riformisti, gli eredi dei “Fasci Siciliani”) e per i “cattolici” (si stavano organizzando i popolari di Sturzo). Ma ancora nelle campagne la maggior parte dei Siciliani era disabituata al voto e la partecipazione cattolica alla vita dello Stato italiano non era ancora completa (il Partito Popolare è del 1919).
Nel 1919 ci furono le prime elezioni con il proporzionale, con collegi provinciali e senza recupero resti. Due anni dopo le circoscrizioni furono ridotte. Furono entrambe elezioni caotiche in un paese allo sbando. Non so perché ma, anche se la partecipazione dei Siciliani andava aumentando, restò minoritaria. E’ un fatto che attende spiegazione. Non dimentichiamo che ancora al 1921 più del 50% dei Siciliani era analfabeta. E naturalmente di voto femminile ancora non se ne parlava.