La Sicilia nella morsa del colonialismo interno. Cosa significa?
Si sente spesso dire che la “Sicilia è una colonia”. Sempre più spesso. Sta diventando ormai una nozione comune anche tra la gente qualunque, e questo è un bene. Ma cosa significa esattamente essere una colonia? In che senso siamo sudditi coloniali? E di chi siamo colonia?
Su questo va fatta – a mio avviso – un po’ di chiarezza.
La prima cosa da fare è quella di distinguere nettamente tra “colonialismo interno” e “colonialismo esterno”.
Quello allo stato puro è il secondo. Una nazione è conquistata. I suoi abitanti non hanno la cittadinanza del paese vincitore, ma assumono quello degradato e ufficiale del suddito coloniale, privo di diritti politici, se non al massimo a livello amministrativo, e con i soli diritti civili, talvolta anche questi menomati e sottoposti a discriminazione ed apartheid da parte dei vincitori o colonizzatori. La colonia ha leggi proprie, governo proprio, certe volte moneta propria, ma tutto è deciso dal paese colonizzatore, al massimo con una partecipazione consultiva da parte del popolo sottomesso. La sua economia è piegata agli interessi della potenza coloniale. Di norma il regime finanziario della colonia deve essere tale che i benefici del paese colonizzatore devono superare i costi di mantenimento della struttura pubblica. Lo Stato colonizzatore è costretto ad erogare, alla meno peggio, alcuni servizi pubblici essenziali, ma l’estrazione di risorse naturali, pagate poco o nulla, compensa il sacrificio. Il paese colonizzato, per tutti i beni e servizi in cui ciò è possibile, deve acquistare ad alto valore aggiunto tutto ciò che viene dal paese colonizzatore, e con la proibizione, formale o sostanziale, di commerciare con altri. Talvolta è tollerata una piccola economia locale di autoconsumo e sussistenza, ma nulla più.
Il colonialismo è uno dei peggiori frutti avvelenati del capitalismo, ma è anche quello che ha consentito, nell’ultimo mezzo millennio, il decollo della civitlà umana, dell’accumulazione del capitale, e quindi anche del progresso tecnologico, economico, e poi anche socio-culturale, dei paesi colonizzatori. Progresso che, poi, fatalmente, si è irradiato anche alle colonie pur in una logica complessiva di rapina.
Rispetto a questa forma classica di colonialismo, che definisco “esterno”, e che ha molte varianti che qui non mette conto richiamare (ad esempio il “protettorato”, in cui si lascia un governo-fantoccio locale a mediare con i sudditi coloniali), molto più interessante e meno indagato è il colonialismo “interno”, di cui la Sicilia attuale è un esempio di scuola, che dobbiamo ora focalizzare.
La colonia “interna” non è ufficialmente tale. Essa, anzi, è dichiarata “territorio metropolitano”. I suoi abitanti sono cittadini del paese colonizzatore. In teoria hanno gli stessi diritti. In pratica hanno sulla carta gli stessi diritti civili ed effettivamente gli stessi diritti politici. Ma da un punto di vista economico e sociale non cambia molto rispetto al modello “esterno”.
Il colonialismo interno è analogo a quello esterno sul piano economico, ma è fondato su una vera e propria ipocrisia istituzionale. Questa a sua volta genera uno scollamento schizofrenico, dentro il paese colonizzato, tra due sotto-paesi: quello legale e quello reale. Quello legale è una sottile patina di funzionari e loro clienti, che vivono “come se” si trovassero nella Madrepatria. Quello reale è derelitto e abbandonato a se stesso.
C’è da dire che il colonialismo esterno può apparire più brutale, ma in realtà è molto più fragile, ed ormai condannato dalla storia. Nessuno può essere a lungo considerato ufficialmente un cittadino di serie B. Il diritto internazionale ha sancito il diritto all’autodeterminazione delle colonie. Tranne in rari casi in cui questa non ha autosufficienza economica o quando, sotto la veste della colonia, è dotata di reale autogoverno, i colonizzati hanno diritto in ogni momento ad essere dichiarati indipendenti. Dopo la II Guerra Mondiale, e ormai da più di 60 anni, il vecchio colonialismo europeo è crollato, sostituito dal “neocolonialismo”, anch’esso oggi in crisi. Sul “neocolonialismo”, cioè sul perpetuarsi del rapporto coloniale anche a indipendenza formale avvenuta, non mi soffermo, tanto è lontano l’esempio dalla Sicilia. Torniamo al colonialismo interno, come si è detto, molto più robusto.
Perché il colonialismo interno è così forte? Perché l’ONU non lo riconosce? Certo, c’è l’ipocrisia istituzionale del considerare i sudditi cittadini, ma questo non spiega tutto. L’Algeria, ad esempio, a differenza delle altre colonie africane, era una “colonia di popolazione”, dove milioni di francesi etnici si erano stabilmente insediati, e agli algerini era stata concessa la piena cittadinanza francese, nella speranza, vana, di assimilarli e di farli diventare francesi a tutti gli effetti. L’Algeria non era colonia, né “Territorio d’Oltremare” (che è lo stesso, detto più “politically correct”), ma … “Francia”. Sicché la Francia non se ne volle andare con le buone. Perché quello che per il “Sudan Francese” (oggi Mali) era indipendenza, per l’Algeria era “secessione”, e quindi attentato all’unità nazionale. C’è voluta una vera e propria guerra civile per ottenere l’indipendenza. Ma perché questa durezza? E perché l’Algeria ce l’ha fatta?
In Algeria l’assimilazione è fallita, nonostante 3 milioni di “pieds noirs” stabilmente trapiantati dalla Francia, e poi ripartiti in fretta e furia, nonostante ad Algeri anche gli Arabi ormai parlassero (e in parte parlano ancora) direttamente il Francese. La società algerina, che aveva pure le sue élite, non si sentì mai francese. Alla fine si arrivò alla rottura, e in Francia nessuno era disposto a morire per Orano o la Cabilia.
Altrove funziona molto meglio. E questo è dovuto ad una piccola grande differenza. Sarà scandaloso dirlo, ma il regime coloniale interno si regge fondamentalmente sul consenso. Una minoranza, politicamente però attiva, dei sudditi coloniali, abbastanza robusta, tiene in ostaggio il resto del paese.
Questa “minoranza collaborazionista” è data da un blocco a tenaglia, dall’alto e dal basso.
Il cosiddetto paese legale controlla la classe dirigente, o gran parte della classe dirigente, della colonia, i cui interessi sono legati a doppio filo a quelli del paese colonizzatore: insegnanti, specie se universitari, magistrati, giornalisti, politici locali, burocrati, imprese appaltatrici pubbliche, poliziotti, militari, prelati, “intellettuali”, “artisti”. Una sottile vernice, rispetto al resto del paese, che vive nel privilegio e come se si trovasse nel paese dominante. Questa classe dominante, in genere parassitaria, pensa di aver tutto da perdere da un salto nel vuoto dell’indipendenza, e diventa formidabile sostenitrice del dominio. Del resto, con la disperazione che gira appena fuori dalla loro porta di casa, si sentono dei veri “miracolati” a non condividere la loro sorte con quella dei conterranei.
A questa classe dirigente coloniale, si aggiungono, dal basso, varie categorie di “clientes”, da piccole partite IVA di beneficiari a raccomandati e assistiti di varia estrazione. Questi legati ai ras locali dei voti da un rapporto di fedeltà che ricorda quello dell’antico feudalesimo.
Le due componenti fanno “blocco” e diventano egemoni.
Il lungo dominio di Orlando a Palermo si spiega così. Il sottoproletariato delle borgate, “comprato” in qualche modo da chi magari ha un ritorno nel sottobosco comunale, che va a braccetto con la professoressa di italiano che risiede in centro, ma che ha ereditato la casa di valore dai genitori, e che si sente “europea” perché abbiamo un abbozzo di piste ciclabili. Un blocco non maggioritario, s’intenda, ma egemone, il che è diverso. Capace di esprimere il 40% della minoranza, sempre più minoranza, dei votanti. Tanto basta…
Gli altri, divisi o delusi, è come se non ci fossero.
Anche se si organizzassero, attraverso sbarramenti “nazionali” o mille altri artifici, sarebbero emarginati.
Naturalmente questo si può fare solo con paesi che, complessivamente, siano demograficamente minoritari rispetto al paese dominante. Così se in Italia sommiamo Sud e Isole, non si raggiunge una maggioranza significativa. L’Italia è una specie di società per azioni in cui gli azionisti di maggioranza, per ovvi motivi geografici e demografici, sono stati sempre i Tosco-Padani. Così come, all’indomani dell’indipendenza, i “Pakistani occidentali” erano soci di maggioranza rispetto ai Bengalesi nel nuovo Pakistan. Anche lì ci volle una guerra civile per liberare il Bangladesh dal Pakistan occidentale.
Altro caso vivente è quello dei paesi caraibici. Guadalupa e Martinica condividono con la Sicilia molto più di quello che condividono con i vicini paesi caraibici ex britannici. A cominciare dalla disoccupazione strutturale.
Già, la disoccupazione, di cui tutti parlano, spesso a vanvera. Mi ha sempre colpito il fatto che un paese sfruttato come un’isola caraibica qualunque avesse tassi di disoccupazione bassi, e i dipartimenti francesi invece alti. Lo stesso dicasi tra le indipendenti Comore, e il dipartimento francese adiacente di Mayotte. La colonia interna, dovendo condividere regime legale, fiscale, e monetario della Madrepatria, diventa un posto per definizione inattrattivo per l’insediamento imprenditoriale.
Con la conseguenza di avere tassi di inoccupazione straordinari. Il paese reale, o illegale, è l’unico che riesce in qualche modo a lavorare, con le dovute eccezioni. Il paese legale ha solo aziende pubbliche, o sostenute dal pubblico, oltre che privati che stanno seduti su una nicchia, come fattori naturali non trasferibili (si pensi all’agricoltura), ovvero servizi che la “Madrepatria” non è riuscita ancora ad offrire in modo coloniale, almeno in modo sistematico (si pensi alle visite mediche specialistiche).
Il disoccupato o emigra, contribuendo alla lenta morte della colonia interna, o si accontenta di qualche sottooccupazione in nero o vive di assistenza, e in entrambi i casi o esce dal gioco politico o diventa ricattabile e sottomesso.
La parte produttiva e indipendente della colonia c’è, ma è minoranza in casa, e il blocco non si rompe, mai.
La storia della mancata attuazione dello Statuto è tutta qua. Chi avrebbe dovuto spingere del resto? Lo Statuto spezza le catene del colonialismo interno, ma questo non conviene alla classe parassitaria locale, non interessa alle masse abbrutite, non è nell’interesse geopolitico e strategico dell’Italia. Tutto qua, la banalità di questo male.
E questo blocco sociale, capace di mascherare abilmente il reale rapporto brutale tra colonizzatore e colonizzato, è temibile, perché può sfidare i decenni, anzi i secoli, come avvenne, in un certo senso, già nella Sicilia romana, o come avvenne a lungo nelle colonie spagnole d’America.
Quindi non c’è niente da fare? Siamo condannati a restare colonia “per sempre”?
Non esageriamo. Il “sempre” è il sempre della storia, cioè è sempre un “sempre” fino a quando….
Fino a quando… che?
Fino a quando non interviene qualcosa a spezzare le catene.
Ciò avviene solo in due casi: la debolezza sopravvenuta del colonizzatore, la forza sopravvenuta del colonizzato.
Nel primo caso (debolezza del colonizzatore) l’élite coloniale non riceve più il suo dividendo di fedeltà e comincia a diventare prima autonomista, poi apertamente indipendentista. La popolazione di clientes è abbandonata al suo destino. L’intero popolo è schiacciato da un’oppressione da colonialismo straccione, ma nessun colonialismo può portare mai alla totale distruzione di un popolo. E così, fatalmente, a un certo punto, il popolo e la sua classe dirigente, cominciano ad avere un processo di “alienazione” dalla dominazione, che a un certo punto, quando il colonizzatore diventa troppo debole, si avvia ad uno strappo.
Nel secondo caso (forza del colonizzato), una parte dell’economia locale, nonostante la colonizzazione, diventa autopropulsiva per fattori esogeni, come ad esempio la presenza di interventi e investimenti esteri. A quel punto, quella parte di società, non colonizzata, comincia ad organizzarsi, prima economicamente e socialmente, poi, fatalmente, in modo politico. Comincia a diventare insofferente del potere centrale, visto solo come fardello, e a un certo punto si arriva alla rottura, anche in questo caso.
E non è detto che le due direzioni non possano andare di pari passo.
La Scozia tende a staccarsi dall’Inghilterra per la progressiva debolezza di questa.
La Catalogna tende a staccarsi dalla Spagna per la sua sempre maggiore forza relativamente al resto del Paese.
Qual è la lezione che ne traiamo dunque per la nostra povera Sicilia? Una sola a mio avviso.
E cioè che il successo dell’imprenditoria siciliana sarà sempre boicottato o comunque visto con sospetto dall’Italia. Perché ciò è contrario agli interessi geopolitici dell’Italia. L’Italia ha interesse solo ad una Sicilia dipendente in tutto e sostanzialmente “malata” al suo interno. E questo da un lato, vedendo le cose da Roma. Dall’altro, vedendo le cose da “Palermo”, se una parte della classe dirigente della Sicilia, soprattutto del suo mondo imprenditoriale, si sarà definitivamente “smottata” dall’Italia, allora si farà sul serio e rapidamente. Dico da “Palermo”, perché alla fine è una parte della classe dirigente della capitale che deve collaborare allo smottamento. Ma il cuore è altrove, sulla costa ionica. Da Ragusa e Siracusa fino a Messina, soprattutto passando per Catania, si deve elaborare il primo nucleo di resistenza sociale ed economica, che poi gemmi negli altri principali centri, del trapanese o dell’interno. Cork era la patria del nazionalismo irlandese, ma solo con una parte dei dublinesi si è potuta fare l’indipendenza.
È sulla costruzione di un’altra Sicilia, pragmatica nel difendere i propri interessi di parte produttiva del Paese, ma lucidi sugli obiettivi strategici di lungo termine, che si deve puntare.
Del resto le vie d’uscita dal colonialismo interno, oltre al suo eterno perpetuarsi senza storia, sembrano solo tre:
la morte del Paese per totale assimilazione (e non c’è mai da stare tranquilli su questo, si pensi allo svuotamento demografico per emigrazione e sostituzione non assimilata di immigrati, ovvero alla “morsa” sciagurata del “ponte”, che visivamente azzanna la Sicilia per incatenarla);
l’emancipazione interna, per attuazione integrale dello Statuto, e progressiva evoluzione del rapporto da coloniale a realmente confederale e poi chissà;
il trauma esterno, come in un ipotetico e frettoloso abbandono del Mediterraneo da parte degli USA, o altri sconvolgimenti globali che colpiscano l’Italia o l’Europa.
In ogni caso, parafrasando Lenin, è necessario un “partito” come “avanguardia della Nazione”, che difenda tatticamente i suoi interessi nel presente come si può, anche in una posizione marginale, e che strategicamente si faccia trovare pronto a prendere le redini, se e quando si realizzerà il “grande evento”.
Che non tarderà.
Intanto a tutti buona Pasqua 2023.
Segui l’autore su Telegram

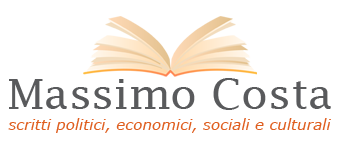



Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!